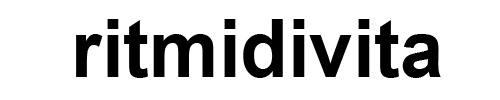Silence di Scorsese
Ieri ho visto Silence, di Martin Scorsese.
Un film lungo, lento e a tratti ostico, un tema non facile perché in apparenza non più attuale: i Gesuiti nel Giappone del 1600, la Novella portata in giro per il mondo. Il film ci ricorda in un sussulto lento ma perentorio, quasi irrompendo nel nostro sguardo tiepido e assuefatto da smartphone, di un tempo in cui ci furono uomini – mai donne – che vagarono per il globo convinti a tal punto della loro fede da non vedere il resto, le altre fedi, l’altrui bellezza. E quindi cercarono spesso con cieca ingenuità di convincere, di “salvare” anime, di esportare la cristianità, ossia un credo – che in quanto tale è un fatto della mente, oggi lo sappiamo.
La mente che chiede sicurezza, che ha bisogno di certezze. E in questa urgenza perde il contatto con il presente, la vita, Dio.
Povero Gesù, se avesse solo immaginato che in migliaia avrebbero provato a far diventare la sua esperienza una “fede” e che avrebbero provato ad innestarla in alberi di luoghi lontani – lui che non cercò di convincere neanche Caifa o Pilato, pur trovandosi davanti a loro, perché aveva il senso del presente, di ciò che c’è e di ciò che non c’è, che non può esserci.
Conosceva il principio di evidenza, Gesù, come è naturale per un essere completo, intero.
A distanza di quasi 30 anni dall’Ultima Tentazione di Cristo, Scorsese riaffronta il tema della fede, della fallacia umana, della cecità che spinge a confondere il soggettivo con l’oggettivo, il relativo con l’assoluto. A confondere la propria verità con una verità più ampia che oggi invece rifiutiamo, per quella legge splendida che ad ogni flusso contrappone un reflusso, com’è giusto che sia.
Eppure Scorsese ci vede lungo, e riesce a far coesistere un parziale risveglio alla realtà del protagonista, con la sua passione viscerale per il suo Gesù, con tutte le note irrazionali, inspiegabili, che questa passione porta con sé. Fino alla morte.
Nel film sembra allora mancare solo un indizio, l’approdo alla Pace. Sarebbe forse bastato il volto di un “Buddha di pietra al tramonto” a darci il senso di ciò che trascende sia l’illusione che il risveglio, sia la fede cieca che l’evidenza. Ecco solo questo mi è mancato, quello che Nisargadatta Maharaj avrebbe chiamato l’Assoluto, e che un regista non può di certo narrare – perché sfugge a qualunque descrizione – ma che avrebbe potuto tacere, nascondere e quindi mettere a disposizione. O forse l’ha fatto, in un suo modo.
Assoluto, Verità, Dio, tutte parole che restano tali se non se ne fa esperienza. Nell’esperienza invece si disperdono, rapide come rondini: resta solo silenzio, come suggerisce il titolo del film, dove ogni contrapposizione, ogni proselitismo, ogni infatuazione muore per dar spazio alla vita.