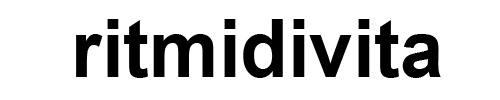Skyros
Solitudine, terra benedetta.
Al mattino mi avvolge cristallino il mare della deserta Skyros, nuda e perfetta come una Musa. Nuoto con braccia lunghe come gomene, il freddo mi chiarisce dentro, sul fondo scorgo una traccia umana, un copertone d’auto – siamo arrivati ovunque. Gettiamo ombre persino nel mare.
A riva tre donne greche gridano come si grida a Roma nei quartieri popolari, parlano di qualcosa che a me sembra nulla, passo veloce oltre, ma non senza il sorriso di chi è ospitato e si sente debitore.
Nei vicoli tortuosi colmi di odori di pietanze mi imbatto nella comunità dei gatti, malinconici siedono con occhi vitrei, uno mi fissa con apparente noncuranza, ma mi teme: ha un occhio solo, l’altro perduto – immagino – in un combattimento. Sono malconci tutti, poca pelle addosso. Ma la comunità è silenziosa e florida, mi piace pensare che un giorno l’isola sarà loro.
In alto la chiesa bianchissima si rivela senza aprirsi, ha il portone serrato: i preti ortodossi si fanno desiderare, quando non ci sono chiudono come facciamo noi in casa nostra.
Queste chiese diafane sembrano provenire dal cielo, le nostre invece partorite dalla terra restano sempre aperte, ma c’è poco vanto: i fedeli entrano ormai tiepidi come turisti, eppur si muovono oggi, come un tempo, in greggi, ieri per fede oggi per superfluità.
L’altro pomeriggio Kostantinos, il padrone di casa, parlava con un uomo, faccia da prete. Scopro poi che è una specie di parroco, mi resta il dubbio se il volto gli sia mutato con la passione religiosa o se sia nato prima, come un marchio di fabbrica cucito addosso fin dall’infanzia, un destino adocchiato dagli amici già tra i banchi della scuola. Scoprirò solo in seguito che ha spiccate abilità canore, di domenica la cerimonia è interminabile, lui canta senza tregua, senza enfasi, le donne entrano ed escono, c’è libertà, nessuno sembra offendersi.
A cerimonia finita le vedo scivolare col capo chino per i vicoli, hanno corpi senza forma, i loro pensieri mi sono ignoti. Con sguardi impassibili, per nulla dissimili dalle nostre isolane, possono passare agevolmente dal sagrato alla piazza, dall’omelia allo spergiuro: anch’esse si muovono nere tra le case bianche, anch’esse non rivelano voluttà, ma fedi cieche, assolute.
Vivo la giornata come viene, tuttavia cerco ordini nuovi, come sempre mi pulisce dentro, l’ordine. Di anno in anno si fa più glabro, punto al minimalismo esistenziale. Fare ciò che va fatto mi mette pace, del resto non trovo altro esito se non questo silenzio di piatti lavati sui quali si specchia il cielo. Di panni stesi per il gioco del meltemi. Ogni tanto mi fermo e suono il flauto, che porto sempre con me.
Di sera, dopo le 6, i negozi aprono e faccio il turista, ma ci credo poco. Mi sento goffo nel girare nelle botteghe che hanno ceramiche e tessuti greci, fingo interessi che non ho, guardo per di più le facce, le persone mi interessano di più dei loro manufatti.
Tra le case bianche trovo un negozio senza tempo: dentro un uomo anziano mi sorride, parla un poco di italiano, è stato in mare e ha conosciuto porti che non conosco, ha vissuto una vita intera che mi inonda nei silenzi lunghi tra le parole.
Si chiama Yannis.
Dei viaggi gli sono rimasti gli occhi, luminosi e sinceri. Del suo tempo gli resta l’innocenza, sembra appena un bambino. Nel negozio non trovo nulla di ciò che cerco, i prezzi sono quelli del 1930, con tre euro compri tutto. Eppure è felice, semplice e libero più di me. Mi accorgo di avere gli occhi zeppi di lacrime, le trattengo a malapena, mi verrebbe da abbracciarlo ma fuori si aggirano donne di paese e già ci additano dell’eresia più antica, l’amore tra pari, la ϕιλία . Compro del sapone e una bottiglia d’acqua, poggio gli spicci su una scrivania dove annota scrupoloso, a penna, ogni accadimento commerciale. Come una volta, prima dei computer. Esco invidiandolo, per poco non finisco giù dal muretto.
Kostantinos mi ha dato una casa benedetta, minuscola, curata ma priva di oggetti che la rendano più che un dormitorio. Non protesto, compro ciò che manca, del resto non sembra ricco, non lo sono neanche io ma chi si svuota le tasche viaggia poi leggero, vola.
Nei giorni successivi mi rivela, con confidenza crescente, che le case che ha sono come un filo teso tra due montagne, facile precipitare: le tasse, come da noi le tasse sono il capestro per la gente semplice, per le masse. Tasse – masse, rima appena scoperta, sorrido per non piangere.
Quando non vago per i vicoli torno nella spiaggia vuota, entro nel mare, prego e chiedo permesso, come mi ha insegnato Pierluigi, santo del mare elbano, ma non ho la sua pazienza né la sua resistenza, nuoto sempre con un sottile filo che mi tiene a riva. Meno di un pensiero. Quanto basta a farmi tornare dopo un esile gruppo di bracciate.
Qui il dio marino è Poseidone (ma loro direbbero Ποσειδών), a lui mi rivolgo sull’uscio, ma non cerco risposta, entro per scomparire.
Quando esco noto con curiosità il buffo aggregarsi umano: tutti insieme in pochi metri di spiaggia (bambini, cani, giochi, seduzioni..) e nessuno per una distesa che appare infinita – e che io ovviamente scelgo.
La sera vedo un pezzo di partita dell’Italia. Non riconosco neanche un nome, seguendo ogni 4 o più anni perdo terreno, non so chi siano questi giocatori fisicati e incerti: i loro nomi non sembrano neanche di terra italica, le facce sono nostre ma hanno una cura per l’aspetto che mi ricorda il grande fratello, i loro parrucchieri provengono da galassie ignote. Sono attori a tempo pieno, non serve salire sul palco, è il palco a portarli in giro. Sono attenti all’aspetto e incerti, o forse incerti perché troppo attenti a ciò che si muove attorno. Vorrei vedere la partita di Abatantuono in Mediterraneo, mi guardo intorno imbarazzato per quegli undici che riflettono la goffaggine di una nazione intera – il ragazzo del bar mi guarda come fossi un marziano.
In cima al paese c’è una scuola, muri dipinti di immagini gigantesche e infantili, meravigliose come sogni. Oltre la terrazza solo il blu del mare. Chissà se studiano come abbiamo fatto noi Ulisse, Agamennone, Paride e gli altri – sembra ormai un sogno quella storia che si intrecciò alla nostra. Quando però poi scendo mi incupisco, i cassonetti della spazzatura non hanno modulazioni di colore, tutto si mischia a tutto. Anche nel market non ero riuscito a sorvolare sulla totale assenza di prodotti ecologici. Sono ridotti in braghe di tela i nostri fratelli greci, mi dico attenuando i toni, ma sedata la condanna resta il dolore.
Mi domando se riusciremo a salvare noi e la Terra, ma non è una domanda onesta. Infatti già dubito, dubito perché vedo che persino le azioni più banali sono eluse: le bottiglie di plastica sono gettate senza averne tolto l’aria da dentro, tracotanti ingombrano anche da defunte. L’avevo notato anche a Roma, a Venezia, a Milano, ovunque. C’è ancora chi si muove con tale incoscienza che si dimentica persino di sfiatare una bottiglia, mi viene in mente ciò che diceva un tale “guarda l’umanità, mentre tu chiedi passi spirituali c’è ancora chi non sa tirare la catena del gabinetto dopo che c’è passato!”
Di sera mi trascino fino alla chiesa, un manovale albanese mi sorride e mi lascia passare oltre il suo lavoro di pittura, parla italiano, anche lui ha girato un pezzetto di mondo e sorride più di me.
Sulla terrazza ecclesiale stendo il mio tappetino come in una cerimonia, il sole sta morendo dietro le colline spoglie. La pratica mi farà tornare fiducioso e benevolo.
Sarà una pratica-morfina quella di stasera.
Del resto ci ricorro sempre più spesso, sono yoga-dipendente, l’ultima volta mi ero fatto una “dose” dopo aver letto la frase di qualche collega che, con l’enfasi di un estremista, inneggiava ad aprire il cakra del cuore. Mi sento tra l’incudine e il martello, o dovrei dire tra la bottiglia di plastica e il guru americano – tra chi non vede e chi fa finta di vedere.
A me il cuore lo apre il volto del vecchio Yannis, o i gatti del vicolo, ma non ci sono posture per questa appartenenza.
Poi inizio a muovere il corpo e tutto si fa più lieve.