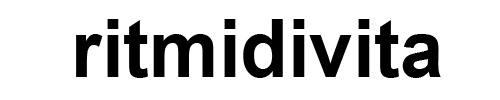Tra Scienza e Spirito
Oggi leggevo un articolo del Corriere sul cancro e la dieta vegana.
Il giornalista, che sembrava narrare con distacco, rivelava invece una sorta di fastidio, l’intolleranza tipica di chi crede di aver colto in fallo l’altro: raccontava di una donna che aveva sbandierato ai 4 venti la propria guarigione da un cancro al seno grazie ad una dieta vegana, questo nel 2015, ora morta di metastasi al polmone e al fegato. La citava come esempio di fanatismo, pressapochismo, resistenza al fatto oggettivo. Ne parlava con rispetto, per carità, ma il giudizio era palese. Parlava di questa cecità di alcuni ambienti (ma non di tutti?), dando al fenomeno un nome interessante, dissonanza cognitiva: quella resistenza, rinvenuta in chi ha un’idea ben strutturata, ad ascoltare ciò che dissente da quell’idea, e che quindi la mette in crisi. Buffo che la citasse rispetto al comportamento della donna e non si rendesse conto di quanto anche la nostra idea di oggettivo, o la sua sottesa riguardo a ciò che è “scientifico”, risenta di altra e ben più stagna struttura, anch’essa chiusa, spessa e invalicabile.
Più morbido di lui Paolo Veronesi, direttore dello IEO, del quale si citava un commento: in un modo bello, non assolutista, diceva che la dieta può aiutare, ma non può fare tutto, i farmaci non possono essere sostituiti. Ovvio mi viene da dire, se bastasse la dieta non ci sarebbero i “morti salutisti”, ci basterebbe allenarci, mangiare bene, essere sani (e magari anche ricchi) per vivere a lungo. E non ci sarebbe quella strana statistica che vede la longevità come prerogativa di popolazioni semplici, poco complesse. Spesso legate alla terra – forse felici, ci viene da pensare. I Sardi con i loro maiali e le loro pecore, ad esempio, o i Greci che mangiano formaggio di capra e bevono un po’ di vino ogni giorno. Popoli definiti “basici”: buffo che il termine identifichi sia un individuo poco “complesso” che un ambiente fisiologico contrapposto a quello acido, quest’ultimo legato alle patologie tra cui sicuramente anche il cancro. I sardi quindi sono alcalini! E i Greci, dipinti dalla UE come falliti, inetti nel gestire il loro Paese – grande menzogna che ha taciuto i fatti veri – sono forse più felici del manager di successo che può tutto, quasi tutto. Tutto meno quello che si chiama serenità, pace.
Essere basici, restare vicini alla base, alla terra – alla polvere direbbero i nostri Vangeli. Essere umili direbbero le Scritture. Ma a noi sembrano solo racconti lontani, fantasie. Erano simboli, li abbiamo lasciati uscire. Li abbiamo persi. Non parlavano necessariamente di fatti storici, ma di evidenze quotidiane, fondamentali per chi vuole crescere, vedere di più.
La medicina studia con grande e stimabile dedizione la chimica di un farmaco che attacchi proprio le cellule tumorali, e solo quelle. E studia il DNA che porta informazioni da lontano. Lo fa perché si è convinta, nella sua struttura di pensiero, dell’identità assoluta tra il visto e l’esistente: quello che posso vedere, misurare, esiste. Il resto no. Da questo poco si discosta il vegano o il salutista o il fanatico dello yoga quando affermano con certezza che quell’alimento, quella modalità di cottura, quella pratica, quella respirazione faranno la differenza. Ancora ricerca di assoluto, di oggettivo, di inconfutabilità. Ma siamo solo il cibo che mangiamo? Siamo solo il corpo e le sue pratiche? Non siamo anche le emozioni, le frasi dette e non dette, le vicende subite, quelle scatenate, i sogni nel cassetto aperto e quelli rimandati? Non siamo anche i nostri nodi mai sciolti, rimossi all’infinito? Sembriamo piuttosto essere una piccola vela in un mare senza confini, e quel mare è la vita, la nostra, così come la stiamo vivendo. Perché ancora ci accontentiamo di parole troppo ampie come “stress”, che dicono tutto per non dire niente, per lasciarci nella nebbia? Se lo stress può creare un reflusso gastrico, una psoriasi, una costipazione cronica, perché non entriamo dentro la parola e accettiamo che il suo significato è proprio “tutto ciò che ancora non so di me”? Che non sappiamo di noi, ma che comunque ci condiziona, ci ostacola, talvolta ci ammala.
Ci vuole una grande maturità psicologica e spirituale per accettare che non sapremo mai misurare oggettivamente quello che siamo, ma saremo forse – spero – in grado di sentire, di essere talmente vicini a noi stessi (al nostro corpo, alle nostre emozioni, ai nostri pensieri) da non fuggire davanti ad alcune evidenze e alle conseguenze che ne derivano. Conseguenze come una malattia, una depressione o, nei casi più indistinti, un senso vago di infelicità che non chiamiamo malattia ma che sarebbe il primo da curare, da abbracciare. Come singoli e come collettività.
Perché vogliamo controllare tutto? La vita, la sua durata, il raccolto dei campi, gli animali che ci assistono, la nostra sopravvivenza? Perché dopo millenni sul pianeta non sappiamo ancora accogliere ciò che viene e che non è in nostro potere dirigere, pilotare? Sui social ci piace la frase che ci invita ad “accettare quello che non possiamo cambiare”, pur evidenziando la difficoltà nel discernere tra ciò che è in nostro potere e ciò che non lo è. Sui social, a parole, è tutto più facile.
La nostra civiltà chiede sopravvivenza, longevità, bellezza eterna. E vuole rimedi veloci, oggettivi, inattaccabili. L’incertezza ci esaspera: possibile che due medici laureati nello stesso anno e nella stessa università facciano diagnosi tanto diverse tra loro? Se questo è così palese, pacifico direi, perché ancora ci prodighiamo nel condannare uno di inettitudine e nell’elogiare l’altro per la sua conoscenza? Sono gli studi a fare la differenza o le intelligenze? E l’intelligenza è figlia della conoscenza intellettuale, è il risultato della quantità di nozioni che occupano il cervello o una specifica capacità di cogliere un insieme di cose, espresse e non espresse, visibili e meno visibili? Come mai il “medico intelligente” ti consiglia di cambiare stile di vita? Cosa ha visto in quello stile che va ad interagire con la sua diagnosi, con il dato materiale?
Forse allora sarebbe meglio non focalizzarci sulle certezze, su ciò che si presume oggettivo, ma accettare che in un evento patologico ci siano una serie di fattori coincidenti, da quello materiale a quello psicologico, dal comportamentale all’emozionale al genetico. Che poi anche il gene non trasporta forse una predisposizione a “reagire a determinati eventi in un determinato modo”? Per alcuni scienziati pare sia proprio così: la capacità della cellula di reagire all’ambiente che la circonda in modo più o meno appropriato. Non sottintende quindi il gene stesso un pacchetto di “comportamenti possibili”, anche in senso lato? Ci sembrano dati certi ma sono metafore, ci parlano di noi. Tutta la Vita ci parla continuamente di noi, per questo si dice sia la più grande maestra.
E poi ancora pochi si domandano perché un cancro attacca il polmone e non lo stomaco, perché il fegato e non l’intestino. Pochi e senza gridarlo, purtroppo, forse perché esiste la resistenza della nostra civiltà – la nostra dissonanza cognitiva collettiva – ad accettare che un tumore possa avere a che fare con noi, che parli di noi, delle cose non risolte, dei nodi mai sciolti, della nostra stessa resistenza. Sì un tumore parla anche della nostra dissonanza, quella che citava giustamente il giornalista. Resistenza a mille possibili variabili, prima fra tutte quella più vicina, che è poi una porta più o meno visibile, talvolta già aperta proprio davanti a noi. Oltre questa c’è il cambiamento, ossia ci attende una vita un po’ più grande di quella di ieri. Perché in realtà noi ci muoviamo per verità via via più ampie, una parte nuova e sconosciuta di noi è sempre in attesa di essere svelata. Un parte di quel mare-vita che è così complesso, immenso, poco definibile, mai governabile. La vita che non si fa mettere in un libro né in una provetta di laboratorio, la vita che però ci segue, che ci insegna, che ci parla di felicità, che ci sorprende – che anzi sorprende solo chi lo ha permesso, chi resta aperto. Chi si chiude non verrà sorpreso. E non si chiude solo il vegano tra vegani, anche l’imprenditore tra impreditori, il bancario nella sua banca, l’avvocato nel suo tribunale. Ognuno tende a rigettare una parte della vita, vederla tutta è pericoloso, fa pensare.
Pochi riflettono sul detto cinese che dice che “il cavallo corre con la biada del giorno prima”, antica saggezza di chi sapeva vedere l’insieme. Se fosse vero, il corpo allora porterebbe frutti di semi già piantati, in un passato poco conosciuto, spesso inconsapevole. E per guarire non basterebbe un evento solo, ma una serie di eventi, che poi non sono che la parte visibile di quel processo che chiamiamo cambiamento. Per guarire basterebbe forse semplicemente cambiare, secondo le medicine più antiche. Ma cosa? Il modo di mangiare? Certo può aiutare, modifica il sostrato fisico. Un farmaco potente? Certo, crea uno shock, uccide cellule nefaste, annienta. Un allenamento? Bello, in un corpo sano la mente è sana. Tutto aiuta ma il cambiamento è qualcosa di più. E’ cedere lo schema, aprirlo, smetterla di essere dissonanti. Quindi ascoltare. Ed ascoltare significa cogliere quello che non siamo.
Allora impareremo forse che non sono le sigarette a creare il cancro ai polmoni ma un atteggiamento netto, ostinato e reiterato di un soggetto che compromette la funzione di un organo, il polmone appunto: una “predisposizione” psicofisica drammatica di cui il fumo non è la causa ma un altro effetto. E, come spesso fanno gli effetti, a sua volta diventa causa. Il fumatore non si ammala perché fuma ma si ammala perché non vuol risolvere ciò che il fumo rivela.
Vogliamo certezze, questo è il problema, mentre l’unica certezza, l’unico dato oggettivo è che non sappiamo ancora cogliere l’insieme, è che gettiamo luce su un fatto oscurandone un altro, che rinunciamo a far sì che il farmaco allopatico aiuti quello naturale, che la mano di un terapeuta aiuti lo scienziato, che il processo psicologico valga quanto quello chimico o chirurgico.
Non ci riusciamo perché non siamo una civiltà guidata dallo spirito, da quella brezza che altre civiltà hanno conosciuto e amato. Siamo una civiltà della sopravvivenza e quindi della paura – di maturare, di invecchiare, di morire. Paura di non essere mai stati.
Quindi valorizziamo tutti i processi quantitativi: numero di esperienze, numero di paesi visitati, numero di banconote in banca, di oggetti posseduti, di amanti avuti, di ricordi, di nozioni. Numeri e non qualità. Eppure ho conosciuto maestri veri, autentici, che avevano la 5a elementare ed erano sempre stati nello stesso, piccolo villaggio. Maestri di felicità, esseri assoluti, completi. Non avevano incertezze da colmare, non avevano certezze se non di essere diventati mare. E quando sei mare accogli tutto, perdoni tutto. Perché ogni cosa è Te.
Essere felici, essere in armonia, nessuno si domanda di questo. La dieta carnea non è il problema del tumore e il veganesimo non ne è la soluzione. Ovvio, un alimento “forte” come la carne, che esprime un’aggressività forte, che implica il sacrificio di un altro essere con occhi e voce mal si addice a popolazioni che l’aggressività negano, che intellettualizzano ogni energia ancestrale e che gli animali quindi schiavizzano. Mangiare carne non fa male all’uomo, ma fa male a noi, noi di adesso, così compressi in spazi angusti, in vite costrette dai desideri di un Io che si inginocchia a nulla, che non ha rispetto per nulla. Ed il consumo della carne, come di tanti altri alimenti, può essere ancor più dannoso per il mondo. Un mondo che disbosca per allevare, per coltivare, per il proprio tornaconto. E’ un fatto di coscienza, non di salute. Se divento vegetariano per la salute sono nella stessa ruota del criceto, nella stessa paura. Se nego la chemioterapia come il medico nega il farmaco omeopatico divento solo un baluardo della contrapposizione, mi chiudo nella torre e resisto. Diverso sarebbe opporsi non a questa o quella cura, qualunque esse siano, ma all’accanimento terapeutico che sembra così bene esprimere il nostro terrore a scomparire, il nostro fraintendimento riguardo a ciò che è vita e ciò che non lo è, la nostra inadeguatezza spirituale, il nostro bisogno di fatti solidi, immutati.
Felicità, qualità di vita, armonia tra gli esseri e il pianeta. Queste le parole chiave. In esse l’Io ha un spazio piccolo, non fa da padrone. Ce l’aveva suggerito anche Francesco, dalla sua minuscola Porziuncola, ma era difficile coglierlo allora, e lo è ancora oggi. L’Io è il problema, non in assoluto ovviamente, ma quando resiste a ciò che lo circonda, quando dissona da ciò che abbiamo chiamato Vita e che i nostri nonni, con più pudore e grazia, chiamavano Dio.